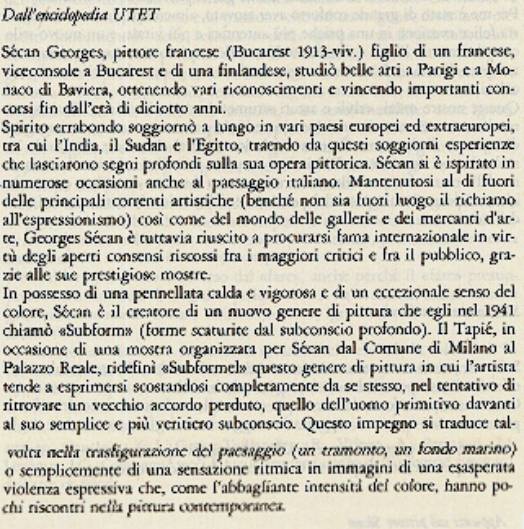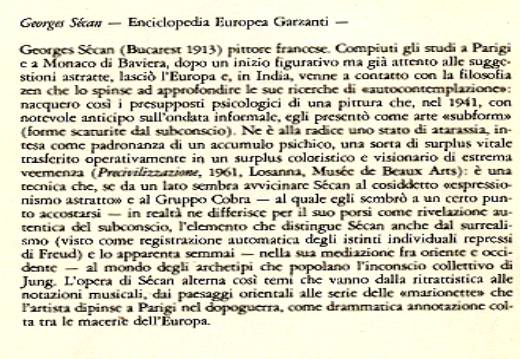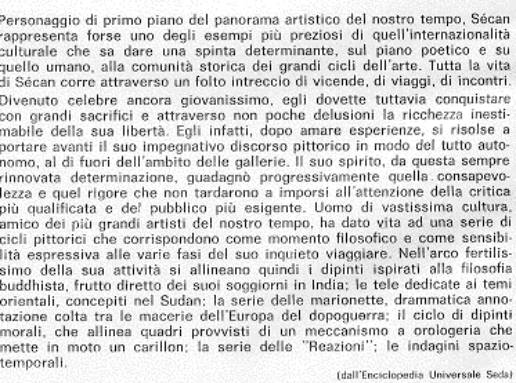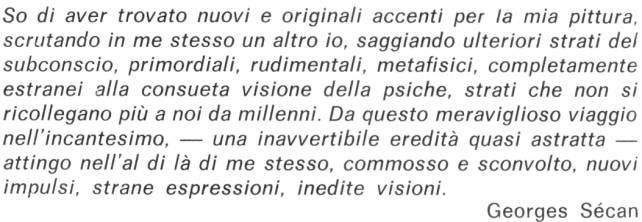Georges Sécan (1913-1987), pittore francese (di origini ebraiche)
|
Dall'Enciclopedia d'Arte Italiana 2013: SÉCAN GeorgesG. Sécan (1913-1987) nasce a Bucarest figlio di un viceconsole francese e di una finlandese. Studiò belle arti a Parigi e a Monaco di Baviera, ottenendo vari riconoscimenti e vincendo importanti concorsi fin dall’età di 18 anni. Soggiornò a lungo in vari paesi europei ed extraeuropei, traendo da questi esperienze che lasciarono segni profondi sulla sua opera pittorica. Si è ispirato in numerose occasioni anche al paesaggio italiano. Mantenutosi al di fuori delle principali correnti artistiche così come del mondo delle gallerie e dei mercanti d’arte, è tuttavia riuscito a procurarsi fama internazionale in virtù degli aperti consensi riscossi fra i maggiori critici e fra il pubblico. Creatore di un nuovo genere di pittura che egli nel 1941 chiamò « Subform ». Il Tapié, ridefinì « Subformel » questo genere di pittura in cui l’artista tende a esprimersi scostandosi completamente da se stesso, nel tentativo di ritrovare un vecchio accordo perduto, quello dell’uomo primitivo davanti al suo semplice e più veritiero subconscio. Questo impegno si traduce talvolta nella trasfigurazione del paesaggio o semplicemente di una sensazione ritmica in immagini di una esasperata violenza espressiva che, come l’abbagliante intensità del colore, ha pochi riscontri nella pittura contemporanea. QUOTAZIONI Questo grande Artista, deceduto da oltre 25 anni , non ha mai avuto Mercanti o Gallerie di riferimento. Ciò è dovuto sicuramente a contrasti di carattere economico, che ebbe in gioventù, con queste tipologie di operatori artistici. Diventa pertanto quasi impossibile dare una corretta valutazione economica a questo eccellente Maestro. Possiamo solo ricordare che negli anni 70, nel periodo in cui venne invitato ad esporre con una Mostra personale al Palazzo Reale di Milano, subito dopo Picasso, le sue quotazioni a livello internazionale avevano raggiunto cifre ragguardevoli. |